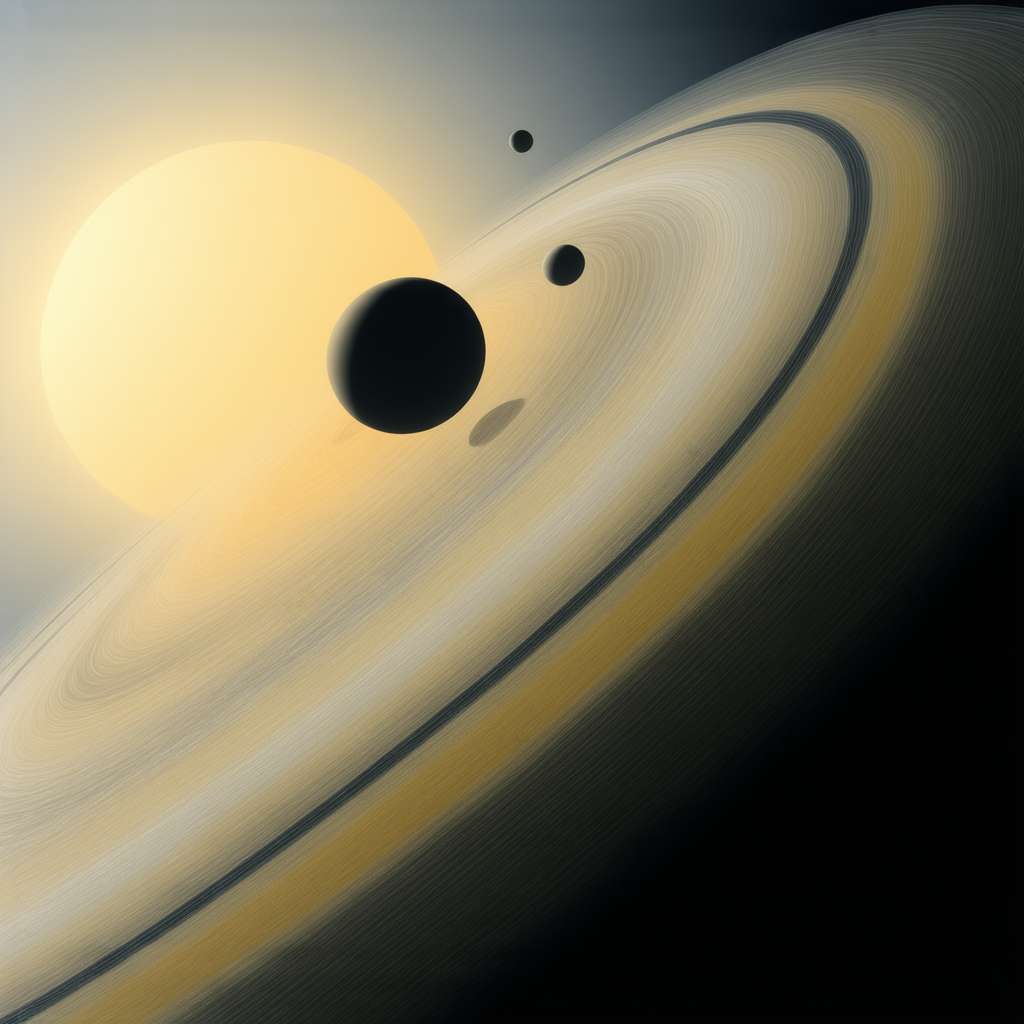E-Mail: [email protected]
- I lanci spaziali contribuiscono allo 0.1% dell'assottigliamento dell'ozono.
- La sindrome di Kessler rende inaccessibile l'orbita bassa.
- L'ESA raccomanda la deorbitazione entro 5 anni dalla fine missione.
L’impronta ecologica dei lanci spaziali
L’esplorazione dello spazio, un’impresa che da sempre affascina l’umanità, ha visto negli ultimi anni una crescita esponenziale, alimentata da investimenti sia pubblici che privati. Questa espansione della Space Economy promette innumerevoli benefici, tra cui l’innovazione tecnologica, la creazione di nuovi posti di lavoro e un avanzamento significativo della conoscenza scientifica. Tuttavia, è fondamentale interrogarsi sull’impatto ambientale di questa attività, in particolare per quanto riguarda i lanci spaziali.
Il lancio di razzi richiede l’impiego di enormi quantità di propellente, la cui combustione rilascia nell’atmosfera gas serra e altre sostanze inquinanti. Sebbene il contributo dei lanci spaziali all’assottigliamento dello strato di ozono sia stimato attualmente inferiore allo 0.1% rispetto ad altre attività umane, come i voli aerei, la crescente frequenza dei lanci impone un’attenta valutazione del rischio. È essenziale considerare le diverse tipologie di propellente utilizzate e il loro specifico impatto ambientale.
I propellenti solidi, ad esempio, sono considerati tra i più inquinanti, poiché rilasciano composti del carbonio, cloruro di idrogeno e particelle di allumina. Il cloruro di idrogeno, in particolare, è dannoso per lo strato di ozono, in quanto i radicali del cloro derivanti dalla sua decomposizione catalizzano la distruzione delle molecole di ozono. D’altra parte, i propellenti liquidi criogenici, come la combinazione di ossigeno e idrogeno liquidi (LOX/LH2), producono principalmente acqua e sono considerati relativamente meno inquinanti. Tuttavia, la loro gestione è complessa e richiede infrastrutture specializzate. I propellenti liquidi a idrocarburi, come il kerosene, rilasciano invece grandi quantità di CO2, contribuendo all’effetto serra e all’aumento delle temperature globali. Infine, i propellenti liquidi ipergolici, come l’idrazina, sono estremamente tossici e inquinanti, soprattutto durante le operazioni di carico e scarico, rappresentando un pericolo per la salute umana e per l’ambiente.

Il problema dei detriti spaziali
Un’altra sfida cruciale per la sostenibilità della Space Economy è rappresentata dalla crescente quantità di detriti spaziali in orbita. Questi detriti, costituiti da frammenti di razzi, satelliti dismessi e altri oggetti artificiali, rappresentano un pericolo per le missioni spaziali attive e future. Le collisioni con i detriti possono danneggiare o distruggere i satelliti, causando interruzioni nei servizi di comunicazione, navigazione e osservazione della Terra. Inoltre, le collisioni generano a loro volta nuovi detriti, innescando un pericoloso effetto a cascata noto come “sindrome di Kessler”.
La sindrome di Kessler, teorizzata nel 1978, descrive uno scenario in cui la densità di detriti spaziali in orbita bassa (LEO) raggiunge livelli tali da rendere le collisioni un evento frequente, innescando una reazione a catena che porta a un incremento esponenziale dei detriti stessi. Questo scenario, se si dovesse concretizzare, renderebbe inaccessibile l’orbita bassa per diverse generazioni, compromettendo in modo irreparabile l’esplorazione spaziale e l’utilizzo dei satelliti artificiali.
È importante sottolineare che la sindrome di Kessler è strettamente connessa al cambiamento climatico. L’aumento dei gas serra nell’atmosfera, pur riscaldando la troposfera, determina un raffreddamento della termosfera, la regione atmosferica in cui orbitano molti satelliti. Questo raffreddamento provoca una contrazione della termosfera, riducendo l’attrito atmosferico che, in condizioni normali, contribuisce alla deorbitazione naturale dei satelliti a fine vita. Di conseguenza, i detriti spaziali rimangono in orbita per un periodo di tempo più lungo, aumentando il rischio di collisioni e accelerando la progressione verso la sindrome di Kessler.
Strategie per una Space Economy sostenibile
Per affrontare le sfide ambientali poste dalla Space Economy e garantire la sua sostenibilità a lungo termine, è necessario adottare strategie innovative e responsabili. Diversi approcci sono attualmente in fase di sviluppo per mitigare l’impatto ambientale dell’esplorazione spaziale.
Lo sviluppo di “propellenti verdi” rappresenta una priorità. Questi propellenti, come l’ossido nitroso, il metano liquido, l’ammoniaca e persino l’iodio solido, offrono un’alternativa più ecologica ai propellenti convenzionali, riducendo le emissioni di gas serra e di sostanze tossiche. Alcune aziende, come l’italiana Avio, stanno già conducendo test promettenti su motori spaziali di nuova generazione che utilizzano propellenti ecocompatibili.
Un’altra strategia fondamentale è la rimozione attiva dei detriti (ADR). Questa tecnologia prevede lo sviluppo di missioni dedicate alla cattura e alla rimozione dei detriti spaziali, utilizzando diverse tecniche, come reti, arpioni o laser. Una volta catturati, i detriti vengono riportati nell’atmosfera terrestre, dove si disintegrano.
La deorbitazione controllata è un’altra strategia essenziale per ridurre il rischio di collisioni e la proliferazione dei detriti. Questo approccio prevede la progettazione dei satelliti in modo che, al termine della loro vita operativa, siano in grado di deorbitarsi autonomamente, utilizzando vele solari, sistemi di propulsione a basso consumo o design che favoriscono la disintegrazione durante il rientro atmosferico. L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) raccomanda una deorbitazione entro cinque anni dalla fine della missione.
Il monitoraggio e il tracciamento dei detriti sono cruciali per prevenire le collisioni. Sistemi avanzati di sorveglianza spaziale consentono di tracciare la posizione e la traiettoria dei detriti, fornendo informazioni preziose per evitare manovre evasive e ridurre il rischio di creare nuovi frammenti.
È inoltre necessario stabilire un quadro normativo internazionale più stringente per regolamentare le attività spaziali e promuovere la sostenibilità. Questo quadro dovrebbe includere standard per la deorbitazione, l’utilizzo di propellenti verdi e la condivisione di informazioni sui detriti spaziali.
Infine, è importante promuovere pratiche di produzione sostenibili all’interno dell’industria spaziale. Questo include l’utilizzo di materiali riciclabili, la riduzione dei consumi energetici nei processi produttivi e la minimizzazione degli scarti. L’adozione di principi di economia circolare, come il recupero e il riutilizzo di componenti satellitari a fine vita, può contribuire a ridurre l’impronta ambientale complessiva della Space Economy.
Prospettive future: verso un’economia spaziale circolare
La Space Economy ha il potenziale per generare benefici inestimabili per l’umanità, ma è imperativo che la sua crescita sia guidata da principi di sostenibilità ambientale. Investire in tecnologie pulite, sviluppare sistemi di rimozione dei detriti, implementare regolamentazioni internazionali efficaci e promuovere pratiche di produzione sostenibili sono passi fondamentali per garantire che l’esplorazione dello spazio non avvenga a spese del nostro pianeta.
La sfida è complessa e richiede un impegno congiunto da parte di governi, aziende e ricercatori. È necessario un cambio di paradigma, in cui la sostenibilità non sia vista come un vincolo, ma come un’opportunità per promuovere l’innovazione e creare una Space Economy più responsabile e resiliente. Solo così potremo garantire che le future generazioni possano beneficiare delle opportunità offerte dallo spazio, senza compromettere l’integrità del nostro ambiente terrestre e spaziale. La sostenibilità della Space Economy* non è solo un imperativo etico, ma anche una necessità pragmatica per garantire la sua prosperità a lungo termine.
Un concetto base della Space Economy legato a questo tema è quello di esternalità negative.* I costi ambientali associati all’inquinamento e ai detriti spaziali sono, appunto, esternalità negative, cioè costi che non sono direttamente sostenuti dalle imprese o dagli individui che svolgono attività spaziali, ma che ricadono sulla società nel suo complesso. Le politiche di sostenibilità mirano a internalizzare questi costi, incentivando le imprese a ridurre il loro impatto ambientale.
Sul fronte più avanzato, possiamo parlare di valutazione del ciclo di vita (LCA) applicata alle missioni spaziali. Questo approccio consiste nell’analizzare l’impatto ambientale di un’attività spaziale durante l’intero suo ciclo di vita, dalla produzione dei componenti, al lancio, all’operatività in orbita e alla deorbitazione. La LCA permette di identificare i punti critici e di adottare soluzioni per ridurre l’impronta ambientale complessiva.
In conclusione, la questione della sostenibilità della Space Economy ci invita a riflettere sul nostro ruolo nell’esplorazione dello spazio. Dobbiamo essere consapevoli del potenziale impatto negativo delle nostre attività e impegnarci a sviluppare tecnologie e politiche che consentano di minimizzarlo. Solo così potremo garantire un futuro sostenibile per l’esplorazione spaziale e per l’intero pianeta.