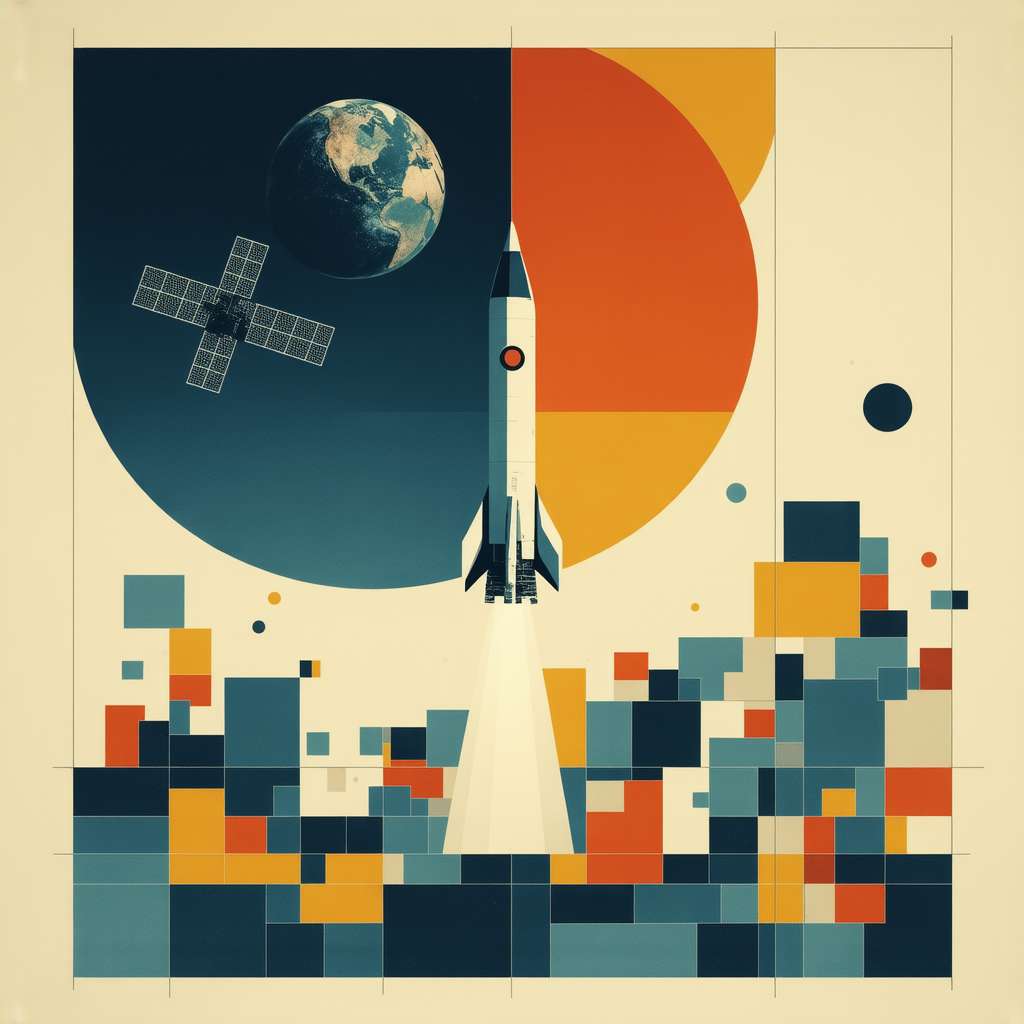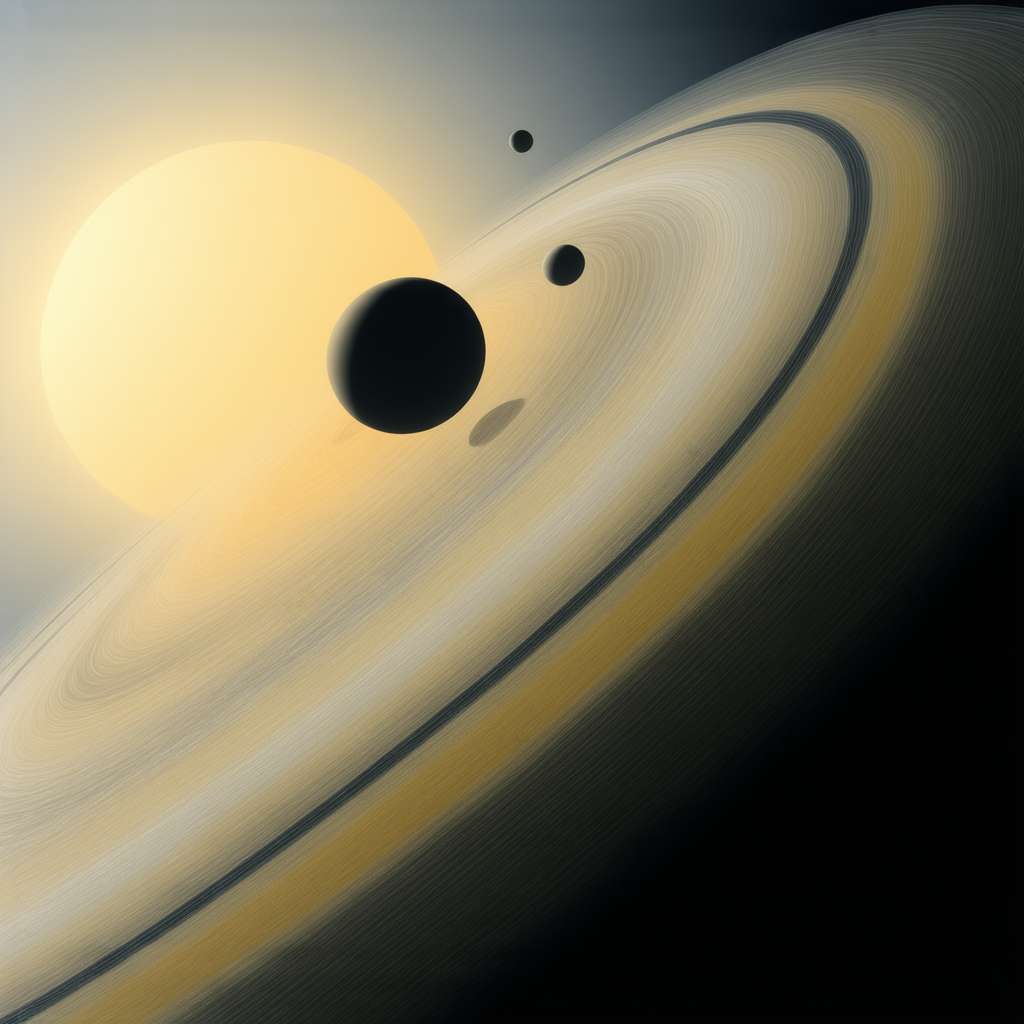E-Mail: [email protected]
- Oltre 23.000 oggetti più grandi di una palla da baseball in orbita.
- Velocità dei detriti spaziali: oltre 27.000 km/h.
- Investimenti europei nello spazio nel 2021: oltre 11 miliardi di dollari.
L’esplorazione e lo sfruttamento dello spazio rappresentano una delle sfide più ambiziose del nostro tempo, ma sollevano interrogativi cruciali sulla sostenibilità ambientale e sociale. Mentre la space economy continua a crescere, attirando investimenti significativi, è imperativo considerare l’impatto delle attività spaziali sull’ambiente terrestre e orbitale. La questione non è solo se possiamo spingerci oltre i confini del nostro pianeta, ma se possiamo farlo in modo responsabile, garantendo che le future generazioni ereditino un ambiente sano e uno spazio accessibile. L’inquinamento orbitale, l’impatto dei lanci e la gestione delle risorse spaziali sono solo alcune delle sfide che richiedono soluzioni innovative e un approccio etico. In questo contesto, i criteri Environmental, Social, and Governance (ESG) stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante, influenzando le decisioni degli investitori e spingendo le aziende spaziali a integrare la sostenibilità nelle loro strategie.
Inquinamento orbitale: una minaccia crescente
L’inquinamento orbitale, o space debris, è una delle maggiori preoccupazioni per la sostenibilità delle attività spaziali. Si tratta di un accumulo di oggetti artificiali in orbita attorno alla Terra, inclusi satelliti dismessi, frammenti di razzi e detriti derivanti da collisioni o esplosioni. La velocità elevatissima con cui questi oggetti si muovono (oltre 27.000 km/h) li rende una minaccia per i satelliti operativi, la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e le future missioni spaziali. La NASA stima che ci siano oltre 23.000 oggetti più grandi di una palla da baseball e milioni di frammenti più piccoli in orbita.
Il problema è aggravato dalla proliferazione di satelliti, soprattutto quelli appartenenti alle mega-costellazioni come Starlink. Se da un lato questi satelliti offrono servizi di connettività globale, dall’altro aumentano il rischio di collisioni e la produzione di nuovi detriti. La questione della responsabilità per la rimozione dei detriti spaziali è complessa, poiché spesso è difficile identificare l’origine degli oggetti.
Diverse agenzie spaziali e aziende private stanno sviluppando tecnologie per affrontare il problema dell’inquinamento orbitale. L’ESA (Agenzia Spaziale Europea) e la US Space Force stanno lavorando a sistemi di monitoraggio per tracciare i detriti e prevedere le collisioni. Alcune soluzioni proposte includono la rimozione attiva dei detriti (ADR), che prevede l’utilizzo di veicoli spaziali per catturare o spingere i detriti fuori dall’orbita, e la progettazione di satelliti con sistemi di deorbitazione automatica a fine vita. Thales Alenia Space ha collaborato alla stesura della legge francese sulla riduzione dei detriti spaziali, considerata un modello a livello internazionale. L’azienda partecipa attivamente anche alla definizione di standard internazionali per la gestione del traffico spaziale.
Tuttavia, la rimozione dei detriti spaziali è una sfida tecnologica ed economica complessa. I costi elevati e le difficoltà tecniche rendono difficile la realizzazione di interventi su larga scala. Inoltre, la questione della governance internazionale è cruciale. Serve un accordo globale che definisca le responsabilità e le regole per la rimozione dei detriti spaziali, evitando che queste attività diventino un’arma geopolitica. Il mancato controllo dell’inquinamento spaziale potrebbe compromettere l’operatività delle infrastrutture satellitari, con gravi conseguenze per le telecomunicazioni, la navigazione, la meteorologia e la sicurezza globale.
Impatto ambientale dei lanci spaziali
Oltre all’inquinamento orbitale, anche l’impatto ambientale dei lanci spaziali rappresenta una sfida per la sostenibilità. I razzi utilizzano propellenti chimici che rilasciano gas serra e altre sostanze inquinanti nell’atmosfera. Anche se il contributo dei lanci spaziali all’inquinamento atmosferico globale è attualmente limitato rispetto ad altre attività umane, si prevede che aumenterà con la crescita della space economy.
L’utilizzo di cherosene come propellente è particolarmente problematico, poiché rilascia grandi quantità di anidride carbonica (CO2) e fuliggine. Altri propellenti, come l’idrogeno liquido e il metano, sono considerati più puliti, ma richiedono tecnologie più complesse e costose. Inoltre, i lanci spaziali possono causare danni allo strato di ozono, soprattutto quelli che utilizzano propellenti a base di cloro.
La ricerca di propellenti alternativi e tecnologie di lancio più sostenibili è in corso. Alcune aziende stanno sperimentando l’utilizzo di biocarburanti o propellenti derivati da fonti rinnovabili. Altre stanno sviluppando sistemi di propulsione elettrica o ibrida, che potrebbero ridurre significativamente le emissioni. La riutilizzabilità dei razzi, come quella promossa da SpaceX, è un altro passo importante verso la riduzione dell’impatto ambientale dei lanci spaziali. Riutilizzare i razzi significa ridurre la produzione di nuovi veicoli e, di conseguenza, il consumo di risorse e l’inquinamento associato.
La sostenibilità dei lanci spaziali non riguarda solo i propellenti. Anche la scelta dei materiali per la costruzione dei razzi e dei satelliti è importante. L’utilizzo di materiali leggeri e riciclabili può ridurre il consumo di risorse e l’impatto ambientale della produzione. Inoltre, è fondamentale considerare l’impatto acustico dei lanci, che può disturbare la fauna selvatica e le comunità locali. La selezione dei siti di lancio e l’adozione di misure di mitigazione del rumore sono importanti per ridurre al minimo questi effetti.

Investimenti Esg e la space economy
Gli investimenti Esg (Environmental, Social, and Governance) stanno diventando sempre più importanti nel settore spaziale. Gli investitori Esg considerano non solo i rendimenti finanziari, ma anche l’impatto ambientale e sociale delle aziende in cui investono. Questo sta spingendo le aziende spaziali a integrare la sostenibilità nelle loro strategie e a comunicare in modo trasparente i loro risultati in termini di Esg.
Un esempio di strumento per valutare la sostenibilità delle aziende spaziali è il questionario P4i, sviluppato da Partners4Innovation. Questo questionario consente alle aziende di misurare il proprio profilo Esg e di identificare aree di miglioramento. Lo standard Sasb (Sustainability Accounting Standards Board) è un altro strumento utile per identificare i temi Esg più rilevanti per il settore spaziale. Il Sasb si basa sul concetto di materialità finanziaria, ovvero sull’identificazione dei temi Esg che potrebbero avere un impatto significativo sulla performance finanziaria delle aziende.
Gli investitori Esg possono influenzare le decisioni delle aziende spaziali in diversi modi. Possono scegliere di investire solo in aziende che soddisfano determinati criteri Esg, oppure possono utilizzare il loro potere di voto per spingere le aziende a migliorare le loro performance in termini di sostenibilità. Inoltre, gli investitori Esg possono promuovere il dialogo con le aziende spaziali, incoraggiandole a adottare pratiche più responsabili.
La transizione verso una space economy più sostenibile richiede un cambiamento di mentalità da parte di tutti gli attori coinvolti. Le aziende spaziali devono riconoscere che la sostenibilità non è solo un costo, ma anche un’opportunità per creare valore a lungo termine. Gli investitori Esg devono essere disposti a sostenere le aziende che si impegnano per la sostenibilità, anche se ciò significa accettare rendimenti finanziari leggermente inferiori nel breve termine. I governi devono creare un quadro normativo che incentivi le pratiche spaziali sostenibili e penalizzi quelle che danneggiano l’ambiente.
La space economy ha un potenziale enorme per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs). Le tecnologie satellitari possono essere utilizzate per monitorare il cambiamento climatico, gestire le risorse naturali, migliorare l’agricoltura, fornire servizi di telecomunicazione nelle aree remote e molto altro ancora. Tuttavia, per realizzare questo potenziale, è fondamentale che la space economy si sviluppi in modo sostenibile, garantendo che le future generazioni possano beneficiare delle opportunità offerte dallo spazio. Nel 2021, gli investimenti europei nello spazio hanno superato gli 11 miliardi di dollari, mentre a livello globale si sono contati oltre 12 miliardi di euro di finanziamenti privati destinati alle startup del settore. L’Italia si posiziona tra i paesi leader per investimenti in rapporto al PIL, evidenziando l’importanza strategica del settore.
Riflessioni sulla sostenibilità spaziale: un imperativo per il futuro
La crescente consapevolezza dell’impatto ambientale e sociale delle attività spaziali ha portato a una maggiore attenzione verso la sostenibilità nel settore. Le aziende spaziali stanno iniziando a integrare i criteri Esg nelle loro strategie, spinte dalla pressione degli investitori e dalla necessità di conformarsi alle normative sempre più stringenti. Tuttavia, la transizione verso una space economy veramente sostenibile richiede un impegno più ampio e una visione a lungo termine.
È necessario sviluppare tecnologie più pulite e efficienti per i lanci spaziali, ridurre l’inquinamento orbitale attraverso la rimozione attiva dei detriti e la progettazione di satelliti con sistemi di deorbitazione automatica, e promuovere una gestione responsabile delle risorse spaziali. Inoltre, è fondamentale garantire che i benefici della space economy siano accessibili a tutti, e che le attività spaziali non contribuiscano a esacerbare le disuguaglianze sociali.
La space economy rappresenta una grande opportunità per l’innovazione e la crescita economica, ma è anche una sfida per la nostra capacità di gestire le risorse in modo responsabile e sostenibile. Il futuro dello spazio dipende dalla nostra capacità di trovare un equilibrio tra profitto e sostenibilità, tra progresso tecnologico e tutela dell’ambiente. Solo così potremo garantire che le future generazioni possano esplorare e beneficiare delle opportunità offerte dallo spazio, senza compromettere il benessere del nostro pianeta.
Vorrei condividere con voi una riflessione. Abbiamo parlato di investimenti Esg e sostenibilità spaziale, concetti che possono sembrare lontani dalla vita di tutti i giorni. In realtà, la space economy è molto più vicina di quanto pensiamo. Ad esempio, i sistemi di navigazione satellitare che utilizziamo quotidianamente per orientarci in auto o a piedi, i servizi di telecomunicazione che ci permettono di comunicare con persone in tutto il mondo, e le previsioni meteorologiche che ci aiutano a pianificare le nostre attività dipendono tutti da infrastrutture spaziali. La space economy è un settore in crescita, con un impatto sempre maggiore sulla nostra vita quotidiana. Una nozione base della space economy è proprio questa: l’integrazione delle tecnologie spaziali nella vita di tutti i giorni.
Ma c’è anche una nozione più avanzata da considerare: quella della “Space Resource Governance”. Si tratta di un campo di studi che si occupa di definire le regole per l’utilizzo delle risorse spaziali, come i minerali presenti sugli asteroidi o l’acqua sulla Luna. Chi ha il diritto di sfruttare queste risorse? Come possiamo evitare che lo sfruttamento delle risorse spaziali diventi una nuova corsa all’oro, con conseguenze negative per l’ambiente e per la giustizia sociale? Queste sono domande complesse che richiedono un dibattito aperto e inclusivo. Spero che questo articolo vi abbia stimolato a riflettere su questi temi, e a considerare il vostro ruolo nel futuro della space economy.